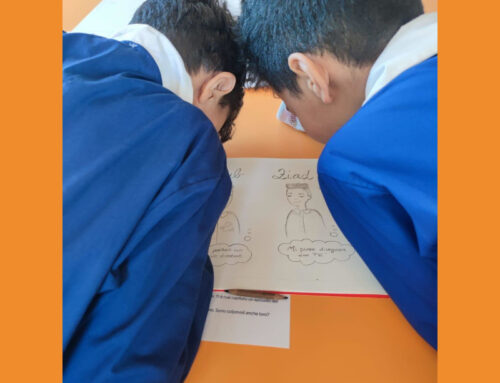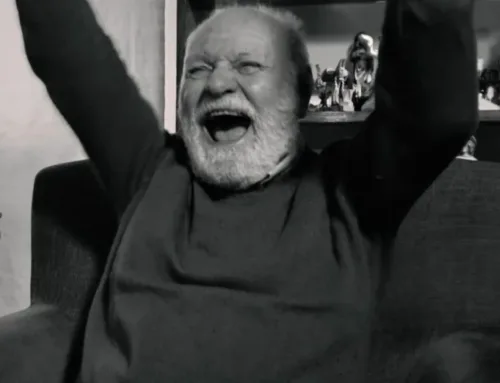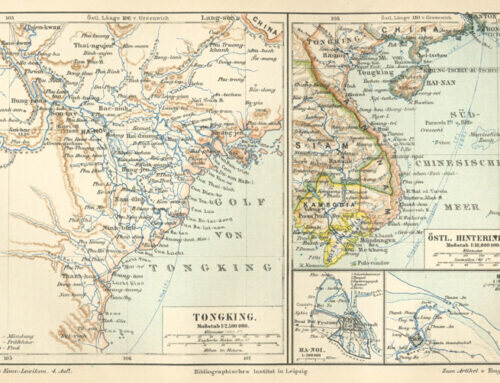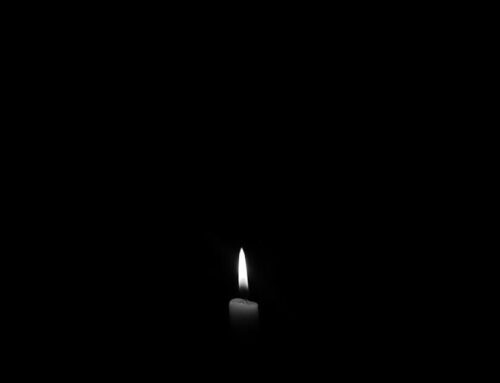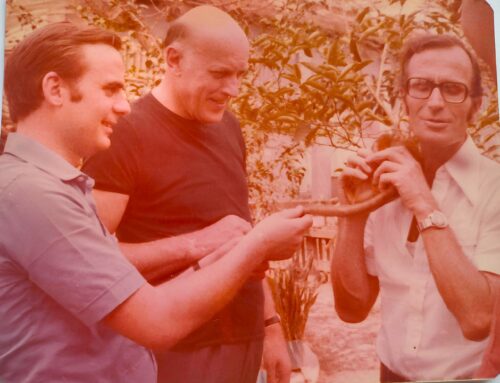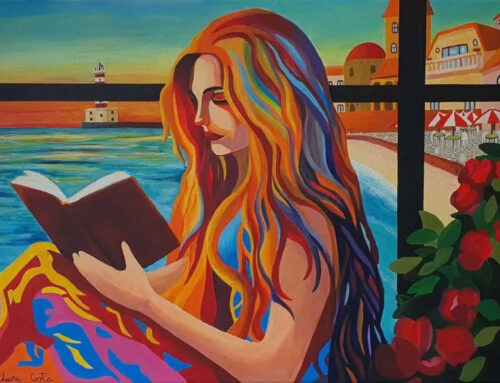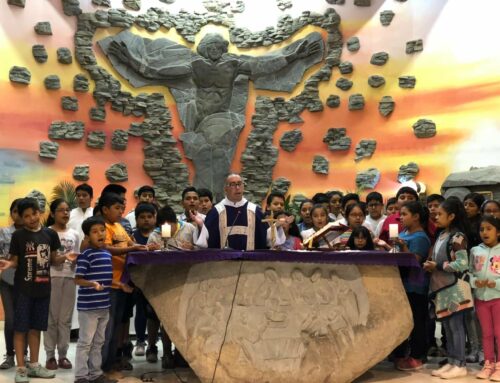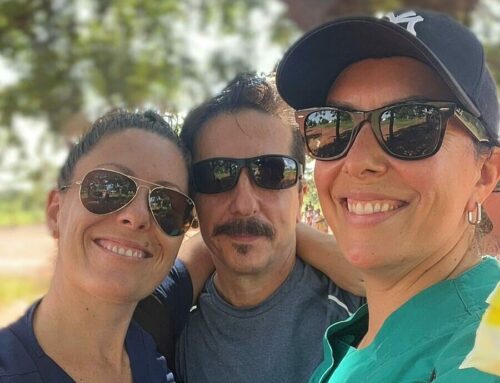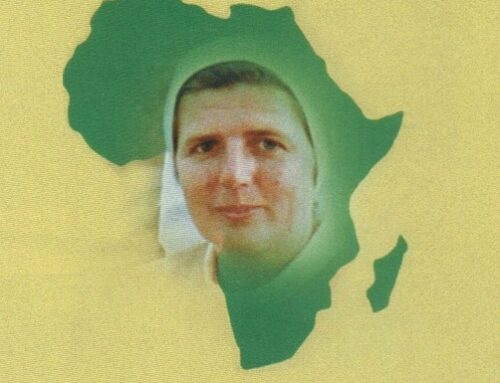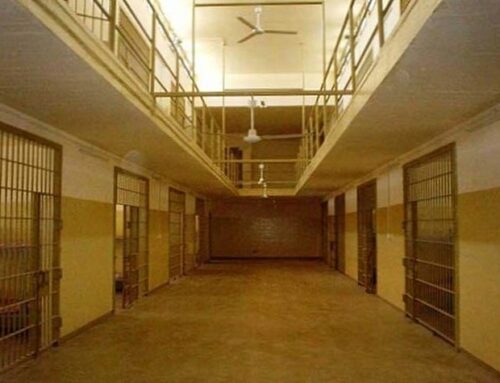Neve Shalom – Wahat al-Salam | Il futuro di pace è già qui

Il dialogo è possibile (Foto di Engin Akyurt - Pexels)
Su Popoli e Missione, un articolo di Chiara Pellicci sul villaggio israeliano “Neve Shalom-Wahat Al-Salam” dove si dialoga e si vive insieme
Rottura, lacerazione, tensione, sofferenza, pretesa che il proprio dolore venga riconosciuto “dall’altra parte”. Sono queste le conseguenze della data-cesura “7 ottobre 2023” sul villaggio israeliano di Neve Shalom – Wahat al-Salam(NSWAS), dove da 50 anni abita una comunità binazionale, quella ebraica e quella palestinese, dimostrando come sia possibile vivere insieme, se alla base della convivenza ci sono accettazione dell’altro, rispetto reciproco, dialogo.
Su una dolce collina tra Tel Aviv e Gerusalemme, in Israele, quest’oasi di pace porta il doppio nome, in ebraico e in arabo, per rispettare le due popolazioni che la abitano, in una terra dove la convivenza è conflittuale.
Ma la sfida delle cento famiglie che oggi compongono il villaggio (50 palestinesi, cristiane o musulmane, 50 ebree israeliane) è proprio quella di dimostrare che si può vivere insieme, perseguendo l’uguaglianza, la democrazia, la parità di diritti, rispettando entrambe le cul ture e le lingue, cancellando ogni privilegio di parte.
Quest’eccezionale villaggio, unico in Israele, è sorto su un terreno del vicino monastero di Latrun concesso nel 1972 al fondatore della comunità, il padre domenicano Bruno Hussar, ebreo convertitosi al cristianesimo e cittadino israeliano. Il suo obiettivo era – ed è – quello di trasformare in un’oasi di pace un luogo di convivenza quotidiana tra due popoli in guerra dal 1948.
Ma dopo il 7 ottobre molti hanno temuto che tutto potesse finire: era più facile arrendersi davanti a quel “troppo”, abbandonare l’idea che la pace è possibile, cedere a chi, nella società israeliana, ha sempre descritto quel villaggio come abitato da «ingenui» o da «poveri illusi».
Invece, pur in questa nuova pagina di terribile Storia, nessuna famiglia ha lasciato la comunità. È iniziato «un faticoso ma indispensabile processo di elaborazione del lutto che è tuttora in corso: incontri periodici tra i residenti, aiutati prima da facilitatori esterni e poi dai mediatori della Scuola per la pace», racconta Giulia Ceccutti, coordinatrice dell’Associazione NSWAS e autrice del libro “Respirare il futuro” (Edizioni In Dialogo).
La Scuola per la pace è il fiore all’occhiello del villaggio, perché qui è racchiusa l’essenza educativa di questo singolare luogo (oltre alla scuola primaria binazionale e bilingue, frequentata al 90% da bambini esterni al villaggio, provenienti dalle vicinanze).
Il programma della Scuola per la pace, aperta nel 1979, prevede seminari, percorsi, incontri, corsi per giovani e adulti che arrivano da ogni parte di Israele e anche dall’estero: alla base di tutto c’è il conflitto israelo-palestinese, con le sue complessità, i luoghi comuni da abbattere, i rapporti di potere e i pregiudizi da mettere a fuoco.
Negli ultimi due anni, mentre nella società israeliana si radicalizzava sempre di più l’insofferenza nei confronti della parte araba, si praticava il silenziamento della comunità palestinese e si riduceva lo spazio per la libertà di espressione per chi voleva esprimere dissenso contro la terribile guerra a Gaza, la Scuola per la pace e tutto il villaggio di NSWAS hanno reagito in senso opposto: «All’inizio non sono mancati scontri accesi, ma subito sono stati messi sul tavolo tutti i problemi, le difficoltà, i vissuti e i traumi; poi, attraverso il dialogo, sono andati avanti», racconta Giulia Ceccutti.
Non solo: sono nate iniziative concrete sia all’interno del villaggio che fuori. Come «la Tenda del Lutto, esperienza unica in Israele, sotto la quale ognuno può esprimere il proprio dolore e condividerlo con gli altri. L’hanno ideata perché si sono accorti che i palestinesi non stavano facendo i tre giorni di lutto con parenti e conoscenti, previsti dalla loro tradizione religiosa, poiché avevano paura di essere accusati dalla polizia di sostegno al terrorismo».
Quindi la Tenda del Lutto è stata un’idea per dare voce, insieme, al dolore silenziato di una parte.
Ma anche all’esterno, gli abitanti del villaggio hanno contribuito a rimettere in moto la ricerca della pace: «Dall’inizio della guerra, ogni settimana scendono dalla collina e lungo l’autostrada manifestano contro la guerra.
Inoltre – aggiunge Ceccutti – il villaggio ha messo a disposizione i suoi locali per altri gruppi e associazioni per la pace che in Israele dopo il 7 ottobre erano stati sfrattati da edifici pubblici: NSWAS è diventato una sorta di hubper per il coordinamento dell’impegno per la pace in Israele. E ancora: è nato il progetto Peace Press, una campagna di pressione mediatica con l’obiettivo di riportare il tema della pace nell’ambito pubblico in Israele, dopo che dal 7 ottobre è sparito del tutto dai media».
Insomma, nonostante tutto, gli “ingenui di NSWAS” continuano a credere che solo il dialogo sia ancora in grado di cambiare le cose. E perseverano nell’impegnarsi a convincere gli inconvincibili
Fonte
- Popoli e Missione, luglio-agosto 2025, pp, 34-35 (articolo di Chiara Pellicci)
Immagine
Su Popoli e Missione, un articolo di Chiara Pellicci sul villaggio israeliano “Neve Shalom-Wahat Al-Salam” dove si dialoga e si vive insieme
Rottura, lacerazione, tensione, sofferenza, pretesa che il proprio dolore venga riconosciuto “dall’altra parte”. Sono queste le conseguenze della data-cesura “7 ottobre 2023” sul villaggio israeliano di Neve Shalom – Wahat al-Salam(NSWAS), dove da 50 anni abita una comunità binazionale, quella ebraica e quella palestinese, dimostrando come sia possibile vivere insieme, se alla base della convivenza ci sono accettazione dell’altro, rispetto reciproco, dialogo.
Su una dolce collina tra Tel Aviv e Gerusalemme, in Israele, quest’oasi di pace porta il doppio nome, in ebraico e in arabo, per rispettare le due popolazioni che la abitano, in una terra dove la convivenza è conflittuale.
Ma la sfida delle cento famiglie che oggi compongono il villaggio (50 palestinesi, cristiane o musulmane, 50 ebree israeliane) è proprio quella di dimostrare che si può vivere insieme, perseguendo l’uguaglianza, la democrazia, la parità di diritti, rispettando entrambe le cul ture e le lingue, cancellando ogni privilegio di parte.
Quest’eccezionale villaggio, unico in Israele, è sorto su un terreno del vicino monastero di Latrun concesso nel 1972 al fondatore della comunità, il padre domenicano Bruno Hussar, ebreo convertitosi al cristianesimo e cittadino israeliano. Il suo obiettivo era – ed è – quello di trasformare in un’oasi di pace un luogo di convivenza quotidiana tra due popoli in guerra dal 1948.
Ma dopo il 7 ottobre molti hanno temuto che tutto potesse finire: era più facile arrendersi davanti a quel “troppo”, abbandonare l’idea che la pace è possibile, cedere a chi, nella società israeliana, ha sempre descritto quel villaggio come abitato da «ingenui» o da «poveri illusi».
Invece, pur in questa nuova pagina di terribile Storia, nessuna famiglia ha lasciato la comunità. È iniziato «un faticoso ma indispensabile processo di elaborazione del lutto che è tuttora in corso: incontri periodici tra i residenti, aiutati prima da facilitatori esterni e poi dai mediatori della Scuola per la pace», racconta Giulia Ceccutti, coordinatrice dell’Associazione NSWAS e autrice del libro “Respirare il futuro” (Edizioni In Dialogo).
La Scuola per la pace è il fiore all’occhiello del villaggio, perché qui è racchiusa l’essenza educativa di questo singolare luogo (oltre alla scuola primaria binazionale e bilingue, frequentata al 90% da bambini esterni al villaggio, provenienti dalle vicinanze).
Il programma della Scuola per la pace, aperta nel 1979, prevede seminari, percorsi, incontri, corsi per giovani e adulti che arrivano da ogni parte di Israele e anche dall’estero: alla base di tutto c’è il conflitto israelo-palestinese, con le sue complessità, i luoghi comuni da abbattere, i rapporti di potere e i pregiudizi da mettere a fuoco.
Negli ultimi due anni, mentre nella società israeliana si radicalizzava sempre di più l’insofferenza nei confronti della parte araba, si praticava il silenziamento della comunità palestinese e si riduceva lo spazio per la libertà di espressione per chi voleva esprimere dissenso contro la terribile guerra a Gaza, la Scuola per la pace e tutto il villaggio di NSWAS hanno reagito in senso opposto: «All’inizio non sono mancati scontri accesi, ma subito sono stati messi sul tavolo tutti i problemi, le difficoltà, i vissuti e i traumi; poi, attraverso il dialogo, sono andati avanti», racconta Giulia Ceccutti.
Non solo: sono nate iniziative concrete sia all’interno del villaggio che fuori. Come «la Tenda del Lutto, esperienza unica in Israele, sotto la quale ognuno può esprimere il proprio dolore e condividerlo con gli altri. L’hanno ideata perché si sono accorti che i palestinesi non stavano facendo i tre giorni di lutto con parenti e conoscenti, previsti dalla loro tradizione religiosa, poiché avevano paura di essere accusati dalla polizia di sostegno al terrorismo».
Quindi la Tenda del Lutto è stata un’idea per dare voce, insieme, al dolore silenziato di una parte.
Ma anche all’esterno, gli abitanti del villaggio hanno contribuito a rimettere in moto la ricerca della pace: «Dall’inizio della guerra, ogni settimana scendono dalla collina e lungo l’autostrada manifestano contro la guerra.
Inoltre – aggiunge Ceccutti – il villaggio ha messo a disposizione i suoi locali per altri gruppi e associazioni per la pace che in Israele dopo il 7 ottobre erano stati sfrattati da edifici pubblici: NSWAS è diventato una sorta di hubper per il coordinamento dell’impegno per la pace in Israele. E ancora: è nato il progetto Peace Press, una campagna di pressione mediatica con l’obiettivo di riportare il tema della pace nell’ambito pubblico in Israele, dopo che dal 7 ottobre è sparito del tutto dai media».
Insomma, nonostante tutto, gli “ingenui di NSWAS” continuano a credere che solo il dialogo sia ancora in grado di cambiare le cose. E perseverano nell’impegnarsi a convincere gli inconvincibili
Fonte
- Popoli e Missione, luglio-agosto 2025, pp, 34-35 (articolo di Chiara Pellicci)
Immagine

Il dialogo è possibile (Foto di Engin Akyurt - Pexels)