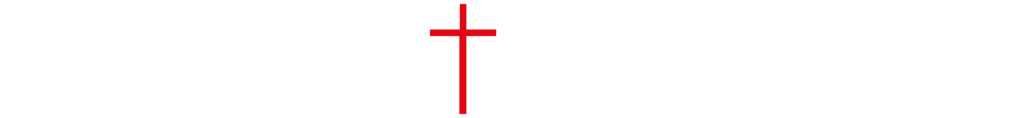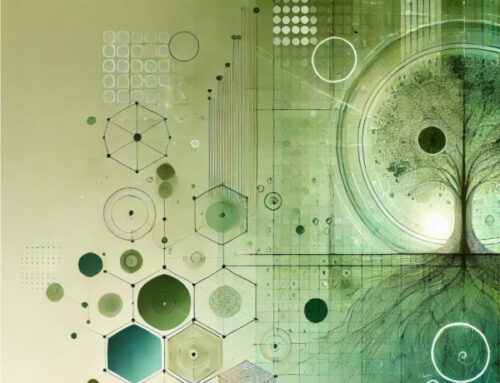La fragilità ci rende umani

Immagine creata digitalmente da spazio + spadoni
Un conto, lo ribadisco, è riconoscere la nostra fragilità,
ma ancora più importante è cogliere quella degli altri,
cosa però difficile se non abbiamo in noi almeno qualche scheggia di fragilità.
(Eugenio Borgna, 2014)
(di Rossella Aiardi)
Quando ho scoperto di essere malata di una patologia cronico-degenerativa avevo appena deciso di diventare infermiera. In quel momento, e per molti anni successivi, non ho pensato a quali ripercussioni queste due condizioni (una scelta, l’altra subita) potessero avere nella mia vita, finché la malattia ha iniziato a lasciare su di me i segni, alcuni visibili, altri celati, della sua presenza.
È difficile, a volte impossibile, ammettere e riconoscere per un curante, le sue intime debolezze: non trovano spazio nei curricula dei professionisti della salute. Ogni forma di fragilità è bandita forse perché, nel pensiero comune, è considerata un elemento di disturbo e destabilizzazione nell’agire quotidianamente la cura verso l’altro.
Eppure chi, tra gli operatori sanitari, può dire di non essersi sentito qualche volta vulnerabile, fragile, in bilico. Incapace di generare una buona cura?
Così per molto tempo la dimensione di essere una curante ha oscurato in me quella di essere, anche, una curata. In fondo io ero colei che prestava le cure alle persone malate e non potevo, certo, permettermi di sostare sul mio problema di salute e sui conti che già cominciavo a pagare: il dolore, il limite, la rabbia.
Questa omissione si è rivelata, più tardi, la mia prima, grande ferita.
Sin dall’inizio del mio lavoro una tensione forte, un desiderio incrollabile di prendermi cura dell’altro prima ancora che di me stessa, mi ha spinto alla ricerca di luoghi di senso che sono stati, senza rendermene conto, balsamo per lenire, anche, per le mie ferite.
E più il tempo della malattia mi sottoponeva a controlli, interventi chirurgici, nuovi approcci terapeutici più quello della cura verso l’altro diventava irrinunciabile, necessario, impellente.
Più scendevo nel mio dolore, più comprendevo l’importanza ed il significato profondo del prendersi cura dell’altro.
Poi, per forza di cose, sei costretta a fermarti. Ed è nella sosta che inizia un altro viaggio, quello verso di te, verso i tuoi bisogni, verso quei luoghi inesplorati e inaccessibili.
Ricordo, perfettamente, l’istante in cui un collega, molti anni fa, all’uscita da un duro turno di lavoro mi rivolse una domanda semplice e diretta: “Come stai?”, mi chiese, incrociando il mio sguardo stravolto.
Qualcuno, quella sera, si era accorto di me.
In quel momento mi sentii con le spalle al muro, fuorigioco, sconfitta. E piansi.
Ma, tra le lacrime, colsi la premura di uno sguardo fraterno, quello stesso sguardo che aveva compreso così bene la stanchezza, il peso, l’affanno che non riuscivo, ormai, più a nascondere e, soprattutto ad ammettere. Mi sono sentita accolta, salvata, non giudicata: quello sguardo che mi aveva messo a nudo, mi dava la possibilità di uscire dalla solitudine in cui ero confinata: forse per pudore, vergogna, per incapacità di riconoscere e dare un nome alla fatica di quel tempo.
Quella fatica, svelata, non era solo del prendersi cura nella sua accezione piena ma, anche, del trovare il giusto equilibrio tra me e l’altro: un’oscillazione costante e impegnativa per non cadere.
Significava sapere fin dove potevo spingermi, quando riconoscere il limite, come canalizzare le risorse e le energie che mi erano rimaste.
Non è stato semplice.
Lentamente ho preso in mano il timone della mia nave. Ho iniziato un cambio di rotta, lenta ma costante, che mi ha permesso di navigare e conoscere nuovi luoghi dove agire la cura, nuovi bisogni da esplorare, nuovi volti da riconoscere: così ho ritrovato sollievo, respiro e senso.
In questa traversata, però, sperimenti la forza del mare: calma piatta e tempesta, brezza leggera e burrasca. Impari a issare le vele e a ripiegarle, ad andare sottocoperta o a calare l’ancora, a mettere il salvagente e stare ben lontano dalla costa. A fare un bagno in mare aperto, felice.
Durante questo viaggio riconosci le tue tante ferite: quelle chiuse e quelle ancora sanguinanti. Il ricordo visibile di un dolore, il sentire invisibile di uno squarcio.
Osservi ciò che rimane: la memoria, scritta sulla carne e sul cuore, di un tragitto inaspettato e faticoso.
Fai esperienza della fragilità: la tua.
La ferita, poi, con il tempo guarisce ma la cicatrice è sempre lì a ricordarti, ogni giorno, la tua “esperienza indesiderata” come la chiama il mio amico Fiorenzo.
Un’esperienza di cui avrei fatto volentieri a meno, che non ho scelto, che mi ha fatto sperimentare la rinuncia, che ha cambiato prospettive e traiettorie, progetti e scopi ma non il desiderio, immutato, di prendermi cura dell’altro: “la mia stella polare”.
Lì è iniziato un lungo e faticoso percorso di consapevolezza che mi ha permesso, finalmente, di guardarmi, di volermi bene, di accettarmi, di perdonarmi, di trovare forze e capacità sconosciute, inedite.
Allora ho compreso che potevo essere infermiera pur riconoscendo e vivendo pienamente la mia malattia. Senza negarla e nasconderla, senza disprezzarla.
Allora ho compreso cosa si prova e come ci si sente sdraiati su un letto di ospedale, immobile per molto tempo, svuotata di emozioni belle, invisibile ai più. Cosa si prova a sentirsi un numero, un organo malato, una malattia da curare.
Allora ho compreso che quella premura che nutrivo verso le persone assistite era la risposta naturale ad un bisogno che avevo sperimentato.
Ho compreso che la cura era, anche, altro.
Quella cura agita dove i gesti hanno un senso, dove i sensi diventano un approdo premuroso ai bisogni di quanti stanno male, dove la relazione è il canale privilegiato che veicola emozioni, storie, vissuti, aspettative, sogni, interrogativi, scelte, battaglie… quella cura, mi ha permesso di riattivare un canale comunicativo verso me stessa.
Ed è nella mia fragilità che ho ritrovato il senso profondo del mio lavoro: l’essenza del prendersi cura.
È nella fragilità che ho riscoperto la mia umanità, punto di contatto con la fragilità dell’altro.
Ma ho dovuto riconoscerla, chiamarla per nome, darle un posto. Farle spazio. Costruire insieme a lei, progettare insieme a lei, camminare insieme a lei. Guardarla negli occhi ma senza soccombere.
Scriverla sul mio curriculum.
Le ho riconosciuto una sapienza e l’ho ascoltata quando si è fatta sentire più forte.
Così ho imparato a prendermi cura di me a diventare la donna che sono.
“Abitare la malattia esercitando un lavoro di cura” non è stato facile.
Non so che professionista sono stata ma so che il mio essere friabile, vulnerabile mi ha collocato in una “duplice prospettiva”: quella di curata e curante insieme, come lo sono molti, donne e uomini, che praticano un lavoro di cura.
Persone, prima ancora che operatori sanitari: tutte destinate alla fragilità.
Ecco perché affrontare questo tema è un atto di coraggio per la comunità dei curanti ed un impegno verso la responsabilità che abbiamo verso i malati e i loro caregiver.
Essere consapevoli di essere anche fragili, significa uscire dalla marginalità, dal silenzio, dal buio e dal senso di colpa. È il primo passo, per i curanti, di ritornare a prendersi cura di loro: il luogo da cui ripartire per generare buone pratiche e buone relazioni.
(Pistoia 15 aprile 2024)
E’ possibile consultare il numero completo della rivista sul sito www.laborcare.it
Leggi gli altri articoli pubblicati
Fonte
Immagine
- Creata digitalmente da spazio + spadoni
Un conto, lo ribadisco, è riconoscere la nostra fragilità,
ma ancora più importante è cogliere quella degli altri,
cosa però difficile se non abbiamo in noi almeno qualche scheggia di fragilità.
(Eugenio Borgna, 2014)
(di Rossella Aiardi)
Quando ho scoperto di essere malata di una patologia cronico-degenerativa avevo appena deciso di diventare infermiera. In quel momento, e per molti anni successivi, non ho pensato a quali ripercussioni queste due condizioni (una scelta, l’altra subita) potessero avere nella mia vita, finché la malattia ha iniziato a lasciare su di me i segni, alcuni visibili, altri celati, della sua presenza.
È difficile, a volte impossibile, ammettere e riconoscere per un curante, le sue intime debolezze: non trovano spazio nei curricula dei professionisti della salute. Ogni forma di fragilità è bandita forse perché, nel pensiero comune, è considerata un elemento di disturbo e destabilizzazione nell’agire quotidianamente la cura verso l’altro.
Eppure chi, tra gli operatori sanitari, può dire di non essersi sentito qualche volta vulnerabile, fragile, in bilico. Incapace di generare una buona cura?
Così per molto tempo la dimensione di essere una curante ha oscurato in me quella di essere, anche, una curata. In fondo io ero colei che prestava le cure alle persone malate e non potevo, certo, permettermi di sostare sul mio problema di salute e sui conti che già cominciavo a pagare: il dolore, il limite, la rabbia.
Questa omissione si è rivelata, più tardi, la mia prima, grande ferita.
Sin dall’inizio del mio lavoro una tensione forte, un desiderio incrollabile di prendermi cura dell’altro prima ancora che di me stessa, mi ha spinto alla ricerca di luoghi di senso che sono stati, senza rendermene conto, balsamo per lenire, anche, per le mie ferite.
E più il tempo della malattia mi sottoponeva a controlli, interventi chirurgici, nuovi approcci terapeutici più quello della cura verso l’altro diventava irrinunciabile, necessario, impellente.
Più scendevo nel mio dolore, più comprendevo l’importanza ed il significato profondo del prendersi cura dell’altro.
Poi, per forza di cose, sei costretta a fermarti. Ed è nella sosta che inizia un altro viaggio, quello verso di te, verso i tuoi bisogni, verso quei luoghi inesplorati e inaccessibili.
Ricordo, perfettamente, l’istante in cui un collega, molti anni fa, all’uscita da un duro turno di lavoro mi rivolse una domanda semplice e diretta: “Come stai?”, mi chiese, incrociando il mio sguardo stravolto.
Qualcuno, quella sera, si era accorto di me.
In quel momento mi sentii con le spalle al muro, fuorigioco, sconfitta. E piansi.
Ma, tra le lacrime, colsi la premura di uno sguardo fraterno, quello stesso sguardo che aveva compreso così bene la stanchezza, il peso, l’affanno che non riuscivo, ormai, più a nascondere e, soprattutto ad ammettere. Mi sono sentita accolta, salvata, non giudicata: quello sguardo che mi aveva messo a nudo, mi dava la possibilità di uscire dalla solitudine in cui ero confinata: forse per pudore, vergogna, per incapacità di riconoscere e dare un nome alla fatica di quel tempo.
Quella fatica, svelata, non era solo del prendersi cura nella sua accezione piena ma, anche, del trovare il giusto equilibrio tra me e l’altro: un’oscillazione costante e impegnativa per non cadere.
Significava sapere fin dove potevo spingermi, quando riconoscere il limite, come canalizzare le risorse e le energie che mi erano rimaste.
Non è stato semplice.
Lentamente ho preso in mano il timone della mia nave. Ho iniziato un cambio di rotta, lenta ma costante, che mi ha permesso di navigare e conoscere nuovi luoghi dove agire la cura, nuovi bisogni da esplorare, nuovi volti da riconoscere: così ho ritrovato sollievo, respiro e senso.
In questa traversata, però, sperimenti la forza del mare: calma piatta e tempesta, brezza leggera e burrasca. Impari a issare le vele e a ripiegarle, ad andare sottocoperta o a calare l’ancora, a mettere il salvagente e stare ben lontano dalla costa. A fare un bagno in mare aperto, felice.
Durante questo viaggio riconosci le tue tante ferite: quelle chiuse e quelle ancora sanguinanti. Il ricordo visibile di un dolore, il sentire invisibile di uno squarcio.
Osservi ciò che rimane: la memoria, scritta sulla carne e sul cuore, di un tragitto inaspettato e faticoso.
Fai esperienza della fragilità: la tua.
La ferita, poi, con il tempo guarisce ma la cicatrice è sempre lì a ricordarti, ogni giorno, la tua “esperienza indesiderata” come la chiama il mio amico Fiorenzo.
Un’esperienza di cui avrei fatto volentieri a meno, che non ho scelto, che mi ha fatto sperimentare la rinuncia, che ha cambiato prospettive e traiettorie, progetti e scopi ma non il desiderio, immutato, di prendermi cura dell’altro: “la mia stella polare”.
Lì è iniziato un lungo e faticoso percorso di consapevolezza che mi ha permesso, finalmente, di guardarmi, di volermi bene, di accettarmi, di perdonarmi, di trovare forze e capacità sconosciute, inedite.
Allora ho compreso che potevo essere infermiera pur riconoscendo e vivendo pienamente la mia malattia. Senza negarla e nasconderla, senza disprezzarla.
Allora ho compreso cosa si prova e come ci si sente sdraiati su un letto di ospedale, immobile per molto tempo, svuotata di emozioni belle, invisibile ai più. Cosa si prova a sentirsi un numero, un organo malato, una malattia da curare.
Allora ho compreso che quella premura che nutrivo verso le persone assistite era la risposta naturale ad un bisogno che avevo sperimentato.
Ho compreso che la cura era, anche, altro.
Quella cura agita dove i gesti hanno un senso, dove i sensi diventano un approdo premuroso ai bisogni di quanti stanno male, dove la relazione è il canale privilegiato che veicola emozioni, storie, vissuti, aspettative, sogni, interrogativi, scelte, battaglie… quella cura, mi ha permesso di riattivare un canale comunicativo verso me stessa.
Ed è nella mia fragilità che ho ritrovato il senso profondo del mio lavoro: l’essenza del prendersi cura.
È nella fragilità che ho riscoperto la mia umanità, punto di contatto con la fragilità dell’altro.
Ma ho dovuto riconoscerla, chiamarla per nome, darle un posto. Farle spazio. Costruire insieme a lei, progettare insieme a lei, camminare insieme a lei. Guardarla negli occhi ma senza soccombere.
Scriverla sul mio curriculum.
Le ho riconosciuto una sapienza e l’ho ascoltata quando si è fatta sentire più forte.
Così ho imparato a prendermi cura di me a diventare la donna che sono.
“Abitare la malattia esercitando un lavoro di cura” non è stato facile.
Non so che professionista sono stata ma so che il mio essere friabile, vulnerabile mi ha collocato in una “duplice prospettiva”: quella di curata e curante insieme, come lo sono molti, donne e uomini, che praticano un lavoro di cura.
Persone, prima ancora che operatori sanitari: tutte destinate alla fragilità.
Ecco perché affrontare questo tema è un atto di coraggio per la comunità dei curanti ed un impegno verso la responsabilità che abbiamo verso i malati e i loro caregiver.
Essere consapevoli di essere anche fragili, significa uscire dalla marginalità, dal silenzio, dal buio e dal senso di colpa. È il primo passo, per i curanti, di ritornare a prendersi cura di loro: il luogo da cui ripartire per generare buone pratiche e buone relazioni.
(Pistoia 15 aprile 2024)
E’ possibile consultare il numero completo della rivista sul sito www.laborcare.it
Leggi gli altri articoli pubblicati
Fonte
Immagine
- Creata digitalmente da spazio + spadoni

Immagine creata digitalmente da spazio + spadoni