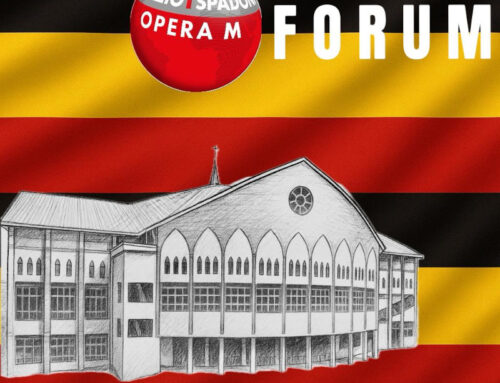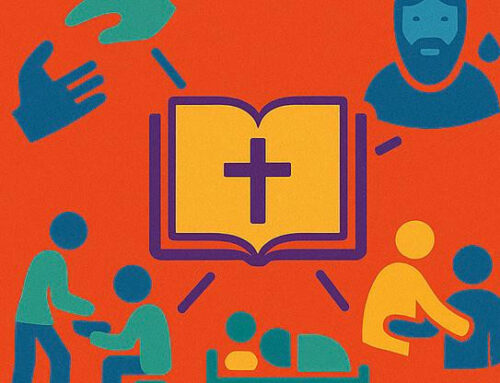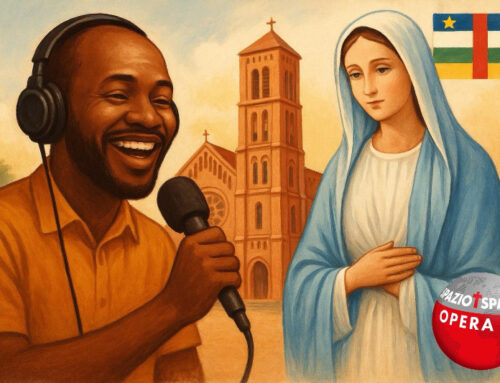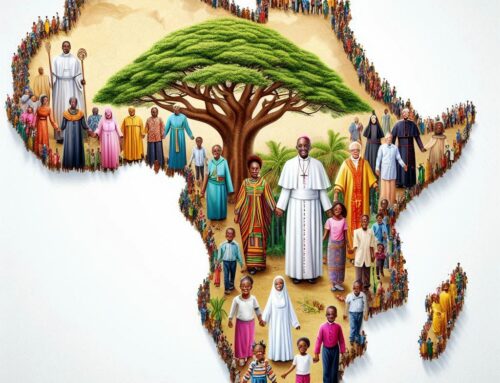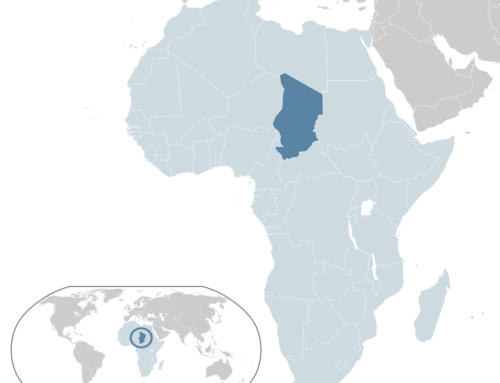Da misericordiati a misericordiosi: il modello esemplare di Bangui

Immagine creata digitalmente da spazio + spadoni
Dalla Repubblica Centrafricana, i riscontri sul Forum di spazio + spadoni sulla RiEvoluzione delle Opere di Misericordia a Bangui
Si è concluso da pochi giorni il Forum inerente la Ri-evoluzione delle Opere di Misericordia che si è tenuto presso la Cattedrale Notre Dame de l’Immaculée Conception, dal 27 al 29 giugno 2025, a Bangui (Repubblica Centroafricana). L’avvenimento si inserisce nel quadro dalla sinergica, operosa e continuativa collaborazione di spazio + spadoni con l’Arcidiocesi di Bangui.
Con gioia ed emozione, possiamo affermare di aver vissuto un evento di indubbio valore e pregnante significato, finalizzato a discernere, analizzare e ricercare strategie d’azione inerenti le Opere di Misericordia Spirituali, grazie anche alla presenza di relatori molto preparati e di un pubblico selezionato di presbiteri, religiose, tutti pronti ad accogliere e interiorizzare i messaggi e a diventare, a loro volta, portavoce e protagonisti attivi nei diversi contesti.
Un Forum, quindi, da assimilare ad altri di cui abbiamo reso testimonianza…
Ciò che, però, ha connotato questo, che non esitiamo a definire singolare ed esemplare, è stata la presenza di un nutrito gruppo di persone a dir poco “speciali”, che comunemente non sono invitate a varcare la soglia di luoghi accreditati o a partecipare a pieno diritto ad eventi importanti: si tratta di coloro che vengono definiti, in base alla loro mancata collocazione sociale, emarginati, vagabondi, senzatetto…
La realtà dello scarto, come ben sappiamo, è un fenomeno che sta dilagando in modo preoccupante e inquietante nei diversi contesti economici e sociali del nostro pianeta. Studiosi a noi contemporanei hanno analizzato a lungo il fenomeno e il filosofo Zygmunt Bauman (Poznan 1925- Leeds 2017) ha individuato nell’ideale dell’Homo oeconomicus, razionale, egoista, che nutre un interesse esclusivo per la cura dei propri interessi individuali, che cerca sempre di ottenere il massimo vantaggio per sé stesso, il simbolo di un nuovo modello sociale dominato dall’emancipazione dalle norme sociali e dalle istituzioni politiche, quindi simbolo della “liquidità”.
La società dell’incertezza, definita anche società liquido-moderna, è luogo di produzione di rifiuti e di esseri umani di scarto. I rifiuti contemporanei sono persone private dei loro modi e mezzi di sopravvivenza, sono gli esuli, i richiedenti asilo e i rifugiati della contemporaneità. La modernità, in quanto progettazione delle forme della comunità umana, è luogo scarti umani, quelli che mal si adattano al modello progettato. Essi sono paragonabili all’homo sacer, colui che nell’antico diritto romano era posto al di fuori della giurisdizione umana senza trapassare in quella divina.
Se questa è la condizione degli Stati, che hanno acconsentito a progettare e creare nuovi luoghi sicuri per lo “smaltimento dei rifiuti umani”, banlieues, nuovi ghetti, campi profughi, totalmente diversa è la proposta, l’invito che ci proviene dalla Parola del Cristo, che ci fa toccare con mano, ci indica la vera Via da percorrere. A testimonianza di ciò, ci sempre importante richiamare alla nostra memoria come i passi evangelici siano disseminati da uomini e donne che nella loro concretezza e disarmante realtà, vivono ai margini delle comunità e che diventano modelli di emarginazione.
Gesù, di fronte alla sofferenza, prova compassione, si pone sullo stesso piano di colui/ colei che è provato dal dolore fisico o interiore, tende la sua mano, stabilisce un contatto diretto, in un rapporto di autentica vicinanza. Poi la guarigione, ma il compito di Gesù va ben oltre. Egli reintegra, include rivoluzionando e scuotendo con forza quella mentalità chiusa nella paura e autolimitata dai pregiudizi. Egli non abolisce la Legge di Mosè ma la porta a compimento (cfr. Mt 5,17), come testimonia il Discorso della Montagna (cfr. Mt 5), che aprendo nuovi orizzonti per l’umanità, rivela pienamente la logica di Dio, quella dell’amore che non si basa sulla paura, ma sulla libertà, sulla carità, sullo zelo sano e sul desiderio salvifico di Dio. Per Gesù ciò che conta, soprattutto, è raggiungere e salvare i lontani, curare le ferite dei malati, reintegrare tutti nella famiglia di Dio.
Il Convegno che apre le porte agli “ultimi” diventa, come abbiamo già detto, esemplare, modello da imitare non solo riguardo all’accoglienza, all’invito, di coloro che solitamente sono scartati, ma nel renderli protagonisti, poiché i “misericordiati” diventano a loro volta portatori di “misericordia”.
Il loro linguaggio delle parole e del corpo è più consono, nella sua semplicità, a consigliare, insegnare, ammonire, consolare, perdonare, sopportare, pregare: a dare concretezza alla logica dell’amore, della carità, del dono.
Il dono all’altro – parola, gesto, dedizione, cura, presenza – è possibile però solo quando si decide la prossimità, il farsi vicino all’altro, il coinvolgersi nella sua vita, il voler assumere una relazione con l’altro. Allora, ciò che era quasi impossibile e comunque difficile, faticoso, diviene quasi naturale perché c’è in noi, nelle nostre profondità la capacità del bene: questa è risvegliata, se non generata, proprio dalla prossimità, quando cessa l’astrazione, la distanza, nasce la relazione e da qui la condivisione.
Gli scartati della società sono coloro che con la loro esperienza di vita, hanno immagazzinato modalità per farsi prossimi, in modo vero ed autentico, pertanto da “misericordiati a misericordiosi” il passo è breve.
Immagine
- Immagine creata digitalmente da spazio + spadoni
Dalla Repubblica Centrafricana, i riscontri sul Forum di spazio + spadoni sulla RiEvoluzione delle Opere di Misericordia a Bangui
Si è concluso da pochi giorni il Forum inerente la Ri-evoluzione delle Opere di Misericordia che si è tenuto presso la Cattedrale Notre Dame de l’Immaculée Conception, dal 27 al 29 giugno 2025, a Bangui (Repubblica Centroafricana). L’avvenimento si inserisce nel quadro dalla sinergica, operosa e continuativa collaborazione di spazio + spadoni con l’Arcidiocesi di Bangui.
Con gioia ed emozione, possiamo affermare di aver vissuto un evento di indubbio valore e pregnante significato, finalizzato a discernere, analizzare e ricercare strategie d’azione inerenti le Opere di Misericordia Spirituali, grazie anche alla presenza di relatori molto preparati e di un pubblico selezionato di presbiteri, religiose, tutti pronti ad accogliere e interiorizzare i messaggi e a diventare, a loro volta, portavoce e protagonisti attivi nei diversi contesti.
Un Forum, quindi, da assimilare ad altri di cui abbiamo reso testimonianza…
Ciò che, però, ha connotato questo, che non esitiamo a definire singolare ed esemplare, è stata la presenza di un nutrito gruppo di persone a dir poco “speciali”, che comunemente non sono invitate a varcare la soglia di luoghi accreditati o a partecipare a pieno diritto ad eventi importanti: si tratta di coloro che vengono definiti, in base alla loro mancata collocazione sociale, emarginati, vagabondi, senzatetto…
La realtà dello scarto, come ben sappiamo, è un fenomeno che sta dilagando in modo preoccupante e inquietante nei diversi contesti economici e sociali del nostro pianeta. Studiosi a noi contemporanei hanno analizzato a lungo il fenomeno e il filosofo Zygmunt Bauman (Poznan 1925- Leeds 2017) ha individuato nell’ideale dell’Homo oeconomicus, razionale, egoista, che nutre un interesse esclusivo per la cura dei propri interessi individuali, che cerca sempre di ottenere il massimo vantaggio per sé stesso, il simbolo di un nuovo modello sociale dominato dall’emancipazione dalle norme sociali e dalle istituzioni politiche, quindi simbolo della “liquidità”.
La società dell’incertezza, definita anche società liquido-moderna, è luogo di produzione di rifiuti e di esseri umani di scarto. I rifiuti contemporanei sono persone private dei loro modi e mezzi di sopravvivenza, sono gli esuli, i richiedenti asilo e i rifugiati della contemporaneità. La modernità, in quanto progettazione delle forme della comunità umana, è luogo scarti umani, quelli che mal si adattano al modello progettato. Essi sono paragonabili all’homo sacer, colui che nell’antico diritto romano era posto al di fuori della giurisdizione umana senza trapassare in quella divina.
Se questa è la condizione degli Stati, che hanno acconsentito a progettare e creare nuovi luoghi sicuri per lo “smaltimento dei rifiuti umani”, banlieues, nuovi ghetti, campi profughi, totalmente diversa è la proposta, l’invito che ci proviene dalla Parola del Cristo, che ci fa toccare con mano, ci indica la vera Via da percorrere. A testimonianza di ciò, ci sempre importante richiamare alla nostra memoria come i passi evangelici siano disseminati da uomini e donne che nella loro concretezza e disarmante realtà, vivono ai margini delle comunità e che diventano modelli di emarginazione.
Gesù, di fronte alla sofferenza, prova compassione, si pone sullo stesso piano di colui/ colei che è provato dal dolore fisico o interiore, tende la sua mano, stabilisce un contatto diretto, in un rapporto di autentica vicinanza. Poi la guarigione, ma il compito di Gesù va ben oltre. Egli reintegra, include rivoluzionando e scuotendo con forza quella mentalità chiusa nella paura e autolimitata dai pregiudizi. Egli non abolisce la Legge di Mosè ma la porta a compimento (cfr. Mt 5,17), come testimonia il Discorso della Montagna (cfr. Mt 5), che aprendo nuovi orizzonti per l’umanità, rivela pienamente la logica di Dio, quella dell’amore che non si basa sulla paura, ma sulla libertà, sulla carità, sullo zelo sano e sul desiderio salvifico di Dio. Per Gesù ciò che conta, soprattutto, è raggiungere e salvare i lontani, curare le ferite dei malati, reintegrare tutti nella famiglia di Dio.
Il Convegno che apre le porte agli “ultimi” diventa, come abbiamo già detto, esemplare, modello da imitare non solo riguardo all’accoglienza, all’invito, di coloro che solitamente sono scartati, ma nel renderli protagonisti, poiché i “misericordiati” diventano a loro volta portatori di “misericordia”.
Il loro linguaggio delle parole e del corpo è più consono, nella sua semplicità, a consigliare, insegnare, ammonire, consolare, perdonare, sopportare, pregare: a dare concretezza alla logica dell’amore, della carità, del dono.
Il dono all’altro – parola, gesto, dedizione, cura, presenza – è possibile però solo quando si decide la prossimità, il farsi vicino all’altro, il coinvolgersi nella sua vita, il voler assumere una relazione con l’altro. Allora, ciò che era quasi impossibile e comunque difficile, faticoso, diviene quasi naturale perché c’è in noi, nelle nostre profondità la capacità del bene: questa è risvegliata, se non generata, proprio dalla prossimità, quando cessa l’astrazione, la distanza, nasce la relazione e da qui la condivisione.
Gli scartati della società sono coloro che con la loro esperienza di vita, hanno immagazzinato modalità per farsi prossimi, in modo vero ed autentico, pertanto da “misericordiati a misericordiosi” il passo è breve.
Immagine
- Immagine creata digitalmente da spazio + spadoni

Immagine creata digitalmente da spazio + spadoni