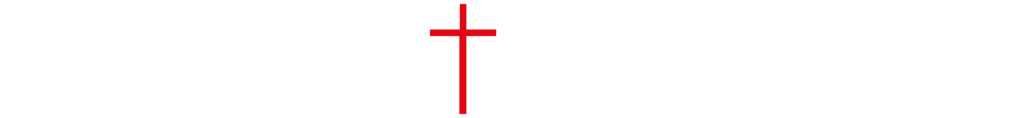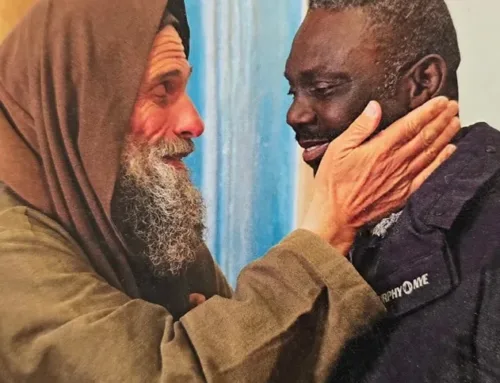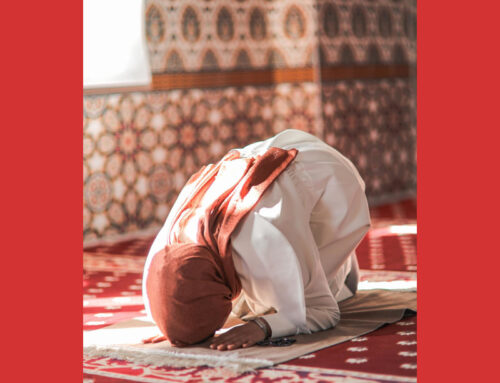Su Gaza e altri conflitti: giustizia, pace e opere di misericordia

In seguito alla manifestazione di solidarietà di Genova, spazio + spadoni si mette in ascolto di un attivista che ha tante cose da dire
INTERVISTA A GIACOMO D’ALESSANDRO
Giacomo è già tra le valli di Cuneo, impegnato in un’altra iniziativa per Gaza, quando lo raggiungiamo al telefono per un’intervista. Lui è un attivista coinvolto in varie associazioni genovesi, pur non rappresentando nessuna realtà specifica; a giugno, è anche stato al Cairo, per partecipare alla “Global March to Gaza” poi bloccata dai governi.
La sua lunga intervista offre diversi spunti e ci apre scenari che fanno riflettere. Il suo racconto è lucido, concreto, ma resta sempre fermo sulla traiettoria della speranza, dell’impegno concreto a cui ciascuno – singolo o popolo – è chiamato, tra responsabilità verso l’umanità (e il suo diritto alla pace e alla giustizia) e opere di misericordia che non lasciano indietro nessuno.
Partiamo dall’impressionante raccolta di viveri per Gaza di cui Genova si è fatta generosamente carico in occasione della partenza delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla.
Si, nei giorni scorsi c’è stata questa iniziativa lanciata da Music for Peace, che è un ONG nata a Genova da Stefano Rebora. Lui era un lavoratore del mondo dello spettacolo – un DJ nelle discoteche – e anni fa ha iniziato a promuovere eventi musicali in cui chiedeva ai partecipanti di portare generi di prima necessità non deperibili come biglietto di ingresso.
Da allora, organizza delle missioni di consegna di aiuti umanitari in Palestina e, a ruota anche in diverse zone complesse del mondo, del Medio Oriente, dell’Africa, ecc.
Hanno ormai uno stile specifico, cioè riempire container con aiuti generi di prima necessità e occuparsi delle spedizioni dall’inizio alla fine, senza intermediari. avere delle relazioni dirette; in più, costruiscono relazioni dirette, con dei progetti che continuano nel tempo. Una delle loro missioni più recenti, per esempio, è stata in Sudan, dove hanno avuto diversi problemi per via dei conflitti.
La bellezza di questa iniziativa è che ha visto la partecipazione, il coinvolgimento e la sinergia di soggetti diversi tra loro, ma uniti da un unico scopo. Ce ne puoi parlare?
Insieme a loro c’era il CALP (Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali), una realtà che in questi ultimi anni è salita agli onori delle cronache anche per l’attenzione ricevuta da Papa Francesco, che li ha portati ad esempio di lavoratori che si organizzano per fare un’azione di denuncia, di protesta, di obiezione di coscienza. In sintesi, il loro credo è questo: “Noi lavoriamo nell’ambito delle spedizioni del carico-scarico-merci portuale, ma alcune cose non le facciamo. Quando si tratta di caricare armi che sappiamo destinate a Paesi in conflitto, ci rifiutiamo, perché viola la sicurezza dei lavoratori e la legge 185 del 1990 che imporrebbe l’obbligo di dichiarare i carichi”.
La loro “disobbedienza civile”, per non rendersi complici di un sistema che crea vittime civili, si scontra ovviamente con diverse difficoltà, tra cui il rischio di perdere il proprio posto di lavoro, ma è molto significativa ed è stata presa a modello anche in altri porti, italiani e non.
Oltre a loro, ho visto muoversi veramente le realtà più disparate: dalla diocesi di Genova con la Caritas, alle Proloco di piccoli paesi dell’Appennino, dai singoli cittadini dei quartieri del centro storico (e anche di quelli più svantaggiati) ai centri di aggregazione culturali, dai gruppi di famiglie alle associazioni, alle imprese, alle catene di grande distribuzione organizzata.
Un movimento trasversale che, in soli tre giorni, ha raccolto circa 260 tonnellate di generi di prima necessità.
Come ha risposto Genova all’appello della Global Sumud Flotilla?
L’appello è stato rivolto a barche, ma soprattutto a navi in grado di portare tonnellate di aiuti e operatori marittimi e sanitari. È importante sottolineare il fatto che ci siano 80 Paesi coinvolti.
Genova ha risposto impegnandosi a raccogliere 40 tonnellate di generi alimentari in 5 giorni, dando vita a una catena di coinvolgimento come raramente si era visto in questi anni, superando poi ogni aspettativa con un approvvigionamento di 6 volte superiore a quanto richiesto.
Qual è il tuo pensiero sul dramma che vive la popolazione di Gaza?
Sappiamo che il tema Palestina è sempre stato divisivo, anche se di fronte alle crisi umanitarie e alle oppressioni bisognerebbe semplicemente riconoscere, a seconda del contesto, chi opprime, chi è oppresso, chi ha le possibilità, essendo in una posizione di forza, di mitigare le cause di un conflitto. In questo caso, Israele avrebbe potuto aiutare piuttosto che continuare le pratiche di apartheid, che anche i sacerdoti (che lavorano da anni nei territori occupati o che vi accompagnano i pellegrini) conoscono da anni e hanno toccato con mano.
Di fronte a questa esasperazione, è sempre molto difficile giudicare la reazione dei popoli oppressi, quella che Paolo VI chiamava la rabbia dei poveri. E’ ovvio che le reazioni violente sono sempre sbagliate, ma dalla nostra posizione privilegiata non possiamo comprendere fino in fondo quanto un’ingiustizia prolungata per decenni possa essere bruciante per chi la subisce.
In questo scenario, qual è il nostro ruolo, da singoli cittadini?
Noi Paesi privilegiati occidentali dovremmo interrogarci se il nostro tipo di filiera economica vada a sostegno delle oppressioni di chi è in posizione di forza. Dove va ad agire il nostro potere geopolitico, chi aiuta, chi sostiene? Sostiene una risoluzione dei conflitti, un compromesso, una diplomazia, una soluzione o va ad armare invece le mani dei più forti?
In questo momento, è tanta la frustrazione anche di assiste impotente a ciò che sta succedendo. E’ avvertita in modo trasversale da migliaia e milioni di persone che probabilmente incarnano molto di più i valori della nostra Costituzione e anche, per chi crede, i valori del Vangelo rispetto a quello che tante volte riescono a fare le relative istituzioni, i governi, ecc.
Nonostante le democrazie e i tanti anni in cui abbiamo avuto modo di elaborare cause e soluzioni dei conflitti, diplomazie, con il lavoro delle Nazioni Unite e il diritto internazionale, ancora oggi ci troviamo in un sistema dove su alcuni aspetti i popoli non riescono ad affermare la loro volontà di pace rispetto ai governi, alle fazioni, alle lobby particolarmente forti nel mondo politico e finanziario, ai mercanti di armi.
Lo diceva fortemente papa Francesco e lo ha ribadito papa Leone XIV già nei suoi primi giorni di pontificato: è veramente un tradimento della volontà dei popoli di avere una vita degna, senza distinzioni. Ci sono risorse e possibilità per tutti e, invece, ci troviamo di fronte a queste situazioni costruite nello scontro geopolitico dove c’è sempre un gruppo di vittime che ci va di mezzo.
Ci racconti la tua esperienza al Cairo della Global March to Gaza?

Giacomo D’Alessandro e la compagna Margherita in Egitto (giugno 2025)
Al Cairo, a giugno, io e la mia compagna Margherita, esponente della Caritas di Genova, ci siamo uniti alla Global March to Gaza, che è stato il primo tentativo a livello globale di convocare cittadini e cittadine nel mettersi in marcia.
Un gesto estremamente pacifico, semplice, per chiedere simbolicamente in migliaia di persone l’apertura all’accesso degli aiuti umanitari, a prescindere dalle cause politiche del dire, dalle ragioni, dai torti, dalle strategie militari o geopolitiche.
Era proprio l’ABC dell’umanità, cioè gli aiuti umanitari devono essere consentiti in qualunque situazione e i diritti umani rispettati.
La proposta in cui ci siamo coinvolti era molto delicata, perché si trattava di andare a mettersi in mano ad uno Stato (l’Egitto) che non è proprio famoso per essere democratico e rispettoso dei diritti umani.
Volevamo tentare una marcia nel deserto di alcuni giorni, molto difficile da organizzare e da prevedere nelle sue evoluzioni, una marcia pacifica fino allo Valico di Raffa. Ovviamente, l’obiettivo era quello di attirare una grande attenzione mediatica, ma anche di creare un imbarazzo diplomatico, sfruttare proprio il privilegio che abbiamo come cittadini di Paesi occidentali, col nostro passaporto di colore rosso o blu, dove invece per altri c’era il rischio di venire aggrediti fisicamente, arrestati, uccisi, ecc. Abbiamo tentato di andarci in migliaia, per costringere le cancellerie e le ambasciate dei governi occidentali a esprimersi su questa situazione e a tutelarci mentre peroravamo la causa degli aiuti umanitari.
Eravamo seimila: duemila erano di questo convoglio Sumud che partiva dai Paesi arabi e quattromila da tutto il mondo arrivati invece via aereo. Ma la marcia è stata bloccata sul nascere, con l’accordo tra i vari governi.
I progetti interrotti o mai partiti lasciano sempre un vuoto dentro… A te cosa è rimasto?
L’Egitto ha fatto una repressione molto dura, rimpatriando persone, arrestandone tante altre, con perquisizioni negli alberghi e tra i vari gruppi che arrivavano, non dando risposte sulle autorizzazioni minime per spostarsi dal Cairo verso il Sinai.
E lo ha potuto fare perché è mancata completamente la tutela minima dei cittadini stranieri da parte dei propri governi. Lo stesso governo italiano aveva emesso una nota dicendo che non avrebbe garantito assistenza consolare a chi partecipava a questa marcia, pur essendo noi persone che si muovevano con un regolarissimo visto turistico.
Da Israele, poi, hanno rincarato dicendo che, se l’Egitto non avesse fermato questa marcia, ci avrebbero pensato loro mandando l’esercito.
Ciò che sembrerebbe la cosa più semplice e anche più innocua – una marcia pacifica dei cittadini del mondo con un regolare visto, arrivati in un Paese dove il turismo esiste e le persone possono girare liberamente – è stato bloccato sul nascere forzando le normative in modo assolutamente ingiustificato. Questo ci dice quanto oggi fa paura la possibilità che visivamente emerga che i popoli desiderano la pace, la diplomazia, il cessate il fuoco, l’affermazione del diritto internazionale.
Se veramente fosse consentito a migliaia di persone di essere viste, fotografate, riprese con le bandiere del mondo, mentre si mettono davanti a una frontiera che non consente di dare cibo a persone, bambini e donne che stanno morendo di fame, questa immagine sarebbe deflagrante, e la volta successiva di persone ce ne sarebbero il doppio.
E succederebbe anche in altri teatri di conflitto?
Sicuramente. In Sudan, in Congo, per i Rohingya, per i Kurdi, in Ucraina, e in tutti quei Paesi in cui la guerra e l’ingiustizia annientano la vita e i diritti della gente.
Fa paura veder crescere un grande movimento pacifista trasversale non violento, che chiede un mondo differente basato su valori differenti, quel movimento che poi ha voluto provare anche un po’ a rianimare papa Francesco con gli incontri dei movimenti popolari, con quei discorsi bellissimi sulle tre T: tierra, techo y trabajo, cioè terra, casa e lavoro.
Questa è stata la nostra esperienza al Cairo con molti limiti, con molta paura anche nel muoversi lì, nel capire cosa poter fare, come coordinarsi a livello internazionale con così tante altre persone.
Il Movimento spazio + spadoni ha a cuore le opere di misericordia, perché generatrici di un’umanità fedelmente vicina ai più fragili. Il tuo impegno e quello di tanti volontari e attivisti è un segno di speranza. Con quale messaggio ci saluti?
La Marcia è stata senz’altro motivo di dubbi, tensioni, sforzo, fatica, perché prendere il coraggio di partire non sapendo cosa può succedere non è facile; tuttavia, ci ha fatto sentire anche quale forza possiamo avere come popoli, almeno come gruppi all’interno di popoli che hanno potuto, grazie magari ai propri percorsi, acquisire un po’ più di strumenti di consapevolezza su alcune tematiche.
Abbiamo visto quanta forza ancora c’è nell’umanità, nella volontà di aggregarsi e di tentare iniziative dal basso laddove i governi non ce la fanno, le Nazioni Unite non ce la fanno, il diritto internazionale non ce la fa.
Io ci ho rivisto molto lo stile di don Tonino Bello quando, nel 1992, entrò in una Sarajevo assediata proprio con questa idea: noi abbiamo il corpo e la forza delle idee, del coraggio, dei valori, della passione anche per il Vangelo per sapere che possiamo anche rischiare qualcosa, metterci di mezzo senza la spada, senza la violenza, senza l’arroganza. Però, solo se lo facciamo in tanti può diventare uno strumento potentissimo per provare a disinnescare una guerra che non ha fine e che travolge tanti civili.
Immagini
- Foto di Giacomo D’Alessandro
In seguito alla manifestazione di solidarietà di Genova, spazio + spadoni si mette in ascolto di un attivista che ha tante cose da dire
INTERVISTA A GIACOMO D’ALESSANDRO
Giacomo è già tra le valli di Cuneo, impegnato in un’altra iniziativa per Gaza, quando lo raggiungiamo al telefono per un’intervista. Lui è un attivista coinvolto in varie associazioni genovesi, pur non rappresentando nessuna realtà specifica; a giugno, è anche stato al Cairo, per partecipare alla “Global March to Gaza” poi bloccata dai governi.
La sua lunga intervista offre diversi spunti e ci apre scenari che fanno riflettere. Il suo racconto è lucido, concreto, ma resta sempre fermo sulla traiettoria della speranza, dell’impegno concreto a cui ciascuno – singolo o popolo – è chiamato, tra responsabilità verso l’umanità (e il suo diritto alla pace e alla giustizia) e opere di misericordia che non lasciano indietro nessuno.
Partiamo dall’impressionante raccolta di viveri per Gaza di cui Genova si è fatta generosamente carico in occasione della partenza delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla.
Si, nei giorni scorsi c’è stata questa iniziativa lanciata da Music for Peace, che è un ONG nata a Genova da Stefano Rebora. Lui era un lavoratore del mondo dello spettacolo – un DJ nelle discoteche – e anni fa ha iniziato a promuovere eventi musicali in cui chiedeva ai partecipanti di portare generi di prima necessità non deperibili come biglietto di ingresso.
Da allora, organizza delle missioni di consegna di aiuti umanitari in Palestina e, a ruota anche in diverse zone complesse del mondo, del Medio Oriente, dell’Africa, ecc.
Hanno ormai uno stile specifico, cioè riempire container con aiuti generi di prima necessità e occuparsi delle spedizioni dall’inizio alla fine, senza intermediari. avere delle relazioni dirette; in più, costruiscono relazioni dirette, con dei progetti che continuano nel tempo. Una delle loro missioni più recenti, per esempio, è stata in Sudan, dove hanno avuto diversi problemi per via dei conflitti.
La bellezza di questa iniziativa è che ha visto la partecipazione, il coinvolgimento e la sinergia di soggetti diversi tra loro, ma uniti da un unico scopo. Ce ne puoi parlare?
Insieme a loro c’era il CALP (Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali), una realtà che in questi ultimi anni è salita agli onori delle cronache anche per l’attenzione ricevuta da Papa Francesco, che li ha portati ad esempio di lavoratori che si organizzano per fare un’azione di denuncia, di protesta, di obiezione di coscienza. In sintesi, il loro credo è questo: “Noi lavoriamo nell’ambito delle spedizioni del carico-scarico-merci portuale, ma alcune cose non le facciamo. Quando si tratta di caricare armi che sappiamo destinate a Paesi in conflitto, ci rifiutiamo, perché viola la sicurezza dei lavoratori e la legge 185 del 1990 che imporrebbe l’obbligo di dichiarare i carichi”.
La loro “disobbedienza civile”, per non rendersi complici di un sistema che crea vittime civili, si scontra ovviamente con diverse difficoltà, tra cui il rischio di perdere il proprio posto di lavoro, ma è molto significativa ed è stata presa a modello anche in altri porti, italiani e non.
Oltre a loro, ho visto muoversi veramente le realtà più disparate: dalla diocesi di Genova con la Caritas, alle Proloco di piccoli paesi dell’Appennino, dai singoli cittadini dei quartieri del centro storico (e anche di quelli più svantaggiati) ai centri di aggregazione culturali, dai gruppi di famiglie alle associazioni, alle imprese, alle catene di grande distribuzione organizzata.
Un movimento trasversale che, in soli tre giorni, ha raccolto circa 260 tonnellate di generi di prima necessità.
Come ha risposto Genova all’appello della Global Sumud Flotilla?
L’appello è stato rivolto a barche, ma soprattutto a navi in grado di portare tonnellate di aiuti e operatori marittimi e sanitari. È importante sottolineare il fatto che ci siano 80 Paesi coinvolti.
Genova ha risposto impegnandosi a raccogliere 40 tonnellate di generi alimentari in 5 giorni, dando vita a una catena di coinvolgimento come raramente si era visto in questi anni, superando poi ogni aspettativa con un approvvigionamento di 6 volte superiore a quanto richiesto.
Qual è il tuo pensiero sul dramma che vive la popolazione di Gaza?
Sappiamo che il tema Palestina è sempre stato divisivo, anche se di fronte alle crisi umanitarie e alle oppressioni bisognerebbe semplicemente riconoscere, a seconda del contesto, chi opprime, chi è oppresso, chi ha le possibilità, essendo in una posizione di forza, di mitigare le cause di un conflitto. In questo caso, Israele avrebbe potuto aiutare piuttosto che continuare le pratiche di apartheid, che anche i sacerdoti (che lavorano da anni nei territori occupati o che vi accompagnano i pellegrini) conoscono da anni e hanno toccato con mano.
Di fronte a questa esasperazione, è sempre molto difficile giudicare la reazione dei popoli oppressi, quella che Paolo VI chiamava la rabbia dei poveri. E’ ovvio che le reazioni violente sono sempre sbagliate, ma dalla nostra posizione privilegiata non possiamo comprendere fino in fondo quanto un’ingiustizia prolungata per decenni possa essere bruciante per chi la subisce.
In questo scenario, qual è il nostro ruolo, da singoli cittadini?
Noi Paesi privilegiati occidentali dovremmo interrogarci se il nostro tipo di filiera economica vada a sostegno delle oppressioni di chi è in posizione di forza. Dove va ad agire il nostro potere geopolitico, chi aiuta, chi sostiene? Sostiene una risoluzione dei conflitti, un compromesso, una diplomazia, una soluzione o va ad armare invece le mani dei più forti?
In questo momento, è tanta la frustrazione anche di assiste impotente a ciò che sta succedendo. E’ avvertita in modo trasversale da migliaia e milioni di persone che probabilmente incarnano molto di più i valori della nostra Costituzione e anche, per chi crede, i valori del Vangelo rispetto a quello che tante volte riescono a fare le relative istituzioni, i governi, ecc.
Nonostante le democrazie e i tanti anni in cui abbiamo avuto modo di elaborare cause e soluzioni dei conflitti, diplomazie, con il lavoro delle Nazioni Unite e il diritto internazionale, ancora oggi ci troviamo in un sistema dove su alcuni aspetti i popoli non riescono ad affermare la loro volontà di pace rispetto ai governi, alle fazioni, alle lobby particolarmente forti nel mondo politico e finanziario, ai mercanti di armi.
Lo diceva fortemente papa Francesco e lo ha ribadito papa Leone XIV già nei suoi primi giorni di pontificato: è veramente un tradimento della volontà dei popoli di avere una vita degna, senza distinzioni. Ci sono risorse e possibilità per tutti e, invece, ci troviamo di fronte a queste situazioni costruite nello scontro geopolitico dove c’è sempre un gruppo di vittime che ci va di mezzo.
Ci racconti la tua esperienza al Cairo della Global March to Gaza?

Giacomo D’Alessandro e la compagna Margherita in Egitto (giugno 2025)
Al Cairo, a giugno, io e la mia compagna Margherita, esponente della Caritas di Genova, ci siamo uniti alla Global March to Gaza, che è stato il primo tentativo a livello globale di convocare cittadini e cittadine nel mettersi in marcia.
Un gesto estremamente pacifico, semplice, per chiedere simbolicamente in migliaia di persone l’apertura all’accesso degli aiuti umanitari, a prescindere dalle cause politiche del dire, dalle ragioni, dai torti, dalle strategie militari o geopolitiche.
Era proprio l’ABC dell’umanità, cioè gli aiuti umanitari devono essere consentiti in qualunque situazione e i diritti umani rispettati.
La proposta in cui ci siamo coinvolti era molto delicata, perché si trattava di andare a mettersi in mano ad uno Stato (l’Egitto) che non è proprio famoso per essere democratico e rispettoso dei diritti umani.
Volevamo tentare una marcia nel deserto di alcuni giorni, molto difficile da organizzare e da prevedere nelle sue evoluzioni, una marcia pacifica fino allo Valico di Raffa. Ovviamente, l’obiettivo era quello di attirare una grande attenzione mediatica, ma anche di creare un imbarazzo diplomatico, sfruttare proprio il privilegio che abbiamo come cittadini di Paesi occidentali, col nostro passaporto di colore rosso o blu, dove invece per altri c’era il rischio di venire aggrediti fisicamente, arrestati, uccisi, ecc. Abbiamo tentato di andarci in migliaia, per costringere le cancellerie e le ambasciate dei governi occidentali a esprimersi su questa situazione e a tutelarci mentre peroravamo la causa degli aiuti umanitari.
Eravamo seimila: duemila erano di questo convoglio Sumud che partiva dai Paesi arabi e quattromila da tutto il mondo arrivati invece via aereo. Ma la marcia è stata bloccata sul nascere, con l’accordo tra i vari governi.
I progetti interrotti o mai partiti lasciano sempre un vuoto dentro… A te cosa è rimasto?
L’Egitto ha fatto una repressione molto dura, rimpatriando persone, arrestandone tante altre, con perquisizioni negli alberghi e tra i vari gruppi che arrivavano, non dando risposte sulle autorizzazioni minime per spostarsi dal Cairo verso il Sinai.
E lo ha potuto fare perché è mancata completamente la tutela minima dei cittadini stranieri da parte dei propri governi. Lo stesso governo italiano aveva emesso una nota dicendo che non avrebbe garantito assistenza consolare a chi partecipava a questa marcia, pur essendo noi persone che si muovevano con un regolarissimo visto turistico.
Da Israele, poi, hanno rincarato dicendo che, se l’Egitto non avesse fermato questa marcia, ci avrebbero pensato loro mandando l’esercito.
Ciò che sembrerebbe la cosa più semplice e anche più innocua – una marcia pacifica dei cittadini del mondo con un regolare visto, arrivati in un Paese dove il turismo esiste e le persone possono girare liberamente – è stato bloccato sul nascere forzando le normative in modo assolutamente ingiustificato. Questo ci dice quanto oggi fa paura la possibilità che visivamente emerga che i popoli desiderano la pace, la diplomazia, il cessate il fuoco, l’affermazione del diritto internazionale.
Se veramente fosse consentito a migliaia di persone di essere viste, fotografate, riprese con le bandiere del mondo, mentre si mettono davanti a una frontiera che non consente di dare cibo a persone, bambini e donne che stanno morendo di fame, questa immagine sarebbe deflagrante, e la volta successiva di persone ce ne sarebbero il doppio.
E succederebbe anche in altri teatri di conflitto?
Sicuramente. In Sudan, in Congo, per i Rohingya, per i Kurdi, in Ucraina, e in tutti quei Paesi in cui la guerra e l’ingiustizia annientano la vita e i diritti della gente.
Fa paura veder crescere un grande movimento pacifista trasversale non violento, che chiede un mondo differente basato su valori differenti, quel movimento che poi ha voluto provare anche un po’ a rianimare papa Francesco con gli incontri dei movimenti popolari, con quei discorsi bellissimi sulle tre T: tierra, techo y trabajo, cioè terra, casa e lavoro.
Questa è stata la nostra esperienza al Cairo con molti limiti, con molta paura anche nel muoversi lì, nel capire cosa poter fare, come coordinarsi a livello internazionale con così tante altre persone.
Il Movimento spazio + spadoni ha a cuore le opere di misericordia, perché generatrici di un’umanità fedelmente vicina ai più fragili. Il tuo impegno e quello di tanti volontari e attivisti è un segno di speranza. Con quale messaggio ci saluti?
La Marcia è stata senz’altro motivo di dubbi, tensioni, sforzo, fatica, perché prendere il coraggio di partire non sapendo cosa può succedere non è facile; tuttavia, ci ha fatto sentire anche quale forza possiamo avere come popoli, almeno come gruppi all’interno di popoli che hanno potuto, grazie magari ai propri percorsi, acquisire un po’ più di strumenti di consapevolezza su alcune tematiche.
Abbiamo visto quanta forza ancora c’è nell’umanità, nella volontà di aggregarsi e di tentare iniziative dal basso laddove i governi non ce la fanno, le Nazioni Unite non ce la fanno, il diritto internazionale non ce la fa.
Io ci ho rivisto molto lo stile di don Tonino Bello quando, nel 1992, entrò in una Sarajevo assediata proprio con questa idea: noi abbiamo il corpo e la forza delle idee, del coraggio, dei valori, della passione anche per il Vangelo per sapere che possiamo anche rischiare qualcosa, metterci di mezzo senza la spada, senza la violenza, senza l’arroganza. Però, solo se lo facciamo in tanti può diventare uno strumento potentissimo per provare a disinnescare una guerra che non ha fine e che travolge tanti civili.
Immagini
- Foto di Giacomo D’Alessandro