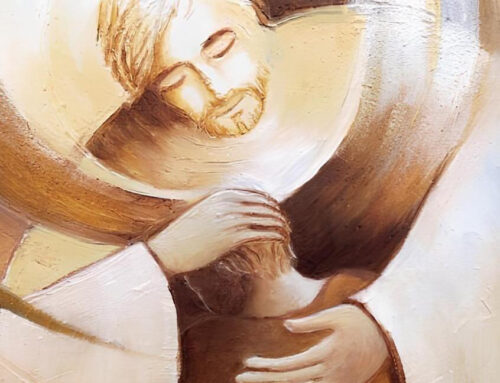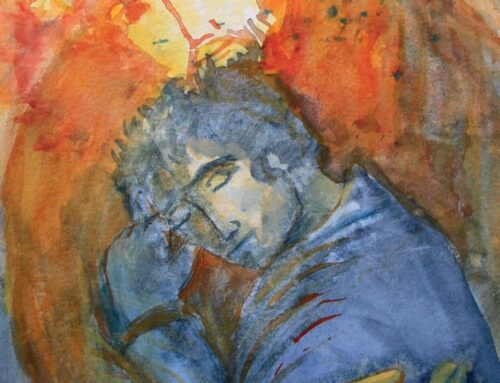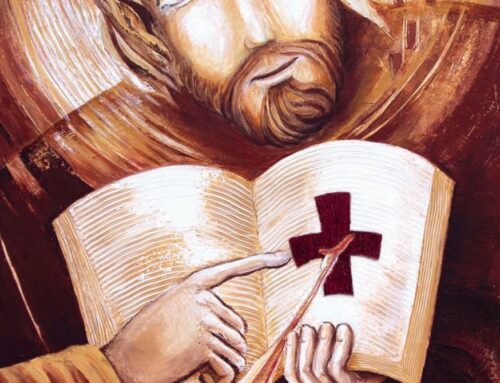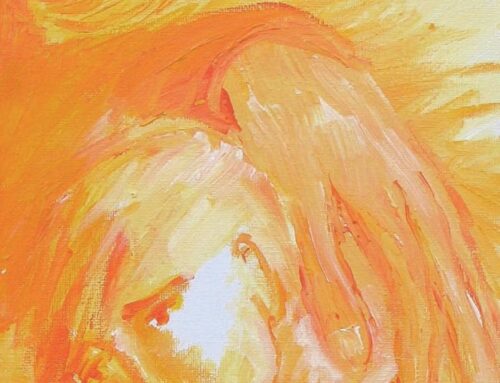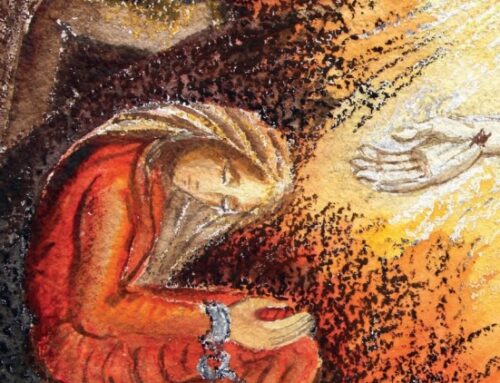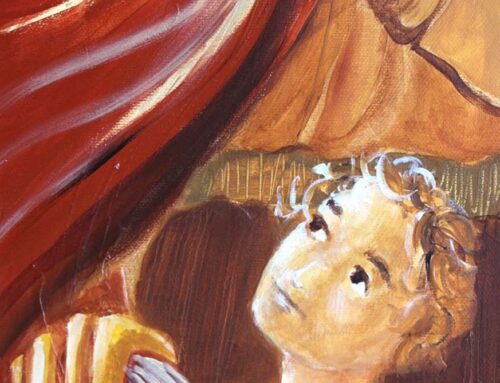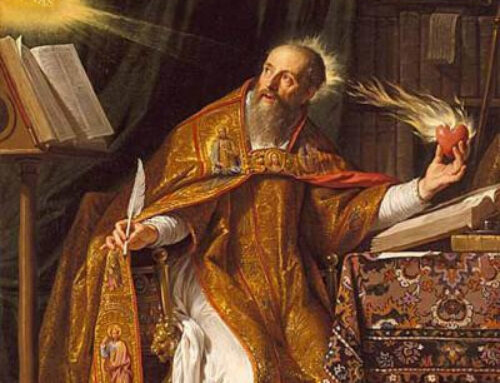Visitare gli infermi

Dal sito dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI, il commento alla quinta opera di misericordia corporale
(di don Carmine Arice,
direttore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale della Salute 2012 – 2017)
Nel racconto evangelico del giudizio finale (cfr Mt 25,31-46) si legge l’ammonimento di Gesù “Ero malato e mi avete visitato” (Mt 25,36). E’ un ammonimento perché alla sera della nostra vita saremo giudicati sull’amore e non sulle buone intenzioni che avremo avuto. E neppure il nostro atto di fede è sufficiente per essere riconosciuti benedetti dal padre di Gesù Cristo, perché “la fede opera per mezzo della carità” (Gal 5,6), ci ricorda l’apostolo Paolo.
La misericordia “si fa”. Scriveva papa Francesco nella Bolla di indizione dell’anno giubilare: “La misericordia di Dio non è un’idea astratta ma una realtà concreta con cui egli rivela il suo amore come quello di un padre di una madre che si commuovono dal profondo delle viscere per il proprio figlio” (Bolla n. 6). Per questo la chiesa parla di opere di misericordia.
La quinta opera di misericordia corporale è visitare gli infermi. Possiamo pensare che nel verbo “visitare”, vi sia anche il verbo assistere, prendersi cura! La visita agli infermi è un momento privilegiato nel quale la comunità ecclesiale porta la luce e la grazia del signore a coloro che soffrono, riconoscendo con umiltà che il Signore Gesù si è identificato con il malato e non con il visitatore.
Rivestito di “sacramentalità cristica”, il malato chiede al visitatore di condividere una dimensione di spoliazione, di impotenza, di povertà. Egli è espressione della comunità cristiana che desidera incontrarsi con il volto di Cristo sofferente. Riconoscendone la sacramentalità e la sua inalterabile dignità, il visitatore entra nella stanza dell’infermo in punta di piedi e con profondo rispetto.
La sofferenza e la malattia aggrediscono l’uomo come i briganti; nella nota parabola lucana del buon samaritano, hanno aggredito il malcapitato. Con il disagio fisico, il malato sperimenta anche la solitudine che nei casi più gravi può farsi anche disperazione.
Il dolore isola. “Colui che soffre fortemente vede dalla sua condizione, con terribile freddezza, le cose al di fuori: tutte quelle piccole ingannevoli magie in cui di consueto nuotano le cose quando l’occhio sano vi si affisse, sono per lui dileguate; anzi egli si pone dinanzi a se stesso privo di orpelli e di colore”.
Malattia, povertà e sofferenza feriscono la persona, aggravando il disagio fisico con quello morale. La nudità nella quale viene lasciato il malcapitato dalla parabola lucana è icona del pudore violato di ogni malato. In lui sempre albergano, anche se inespressi, la domanda di senso e il peso dei suoi problemi esistenziali.
Visitare il malato significa allora offrire con discrezione, amore e competenza, una vicinanza per attraversare insieme il guado della malattia, sentirsi meno solo e percepire, anche se permanentemente infermo in un letto, di essere parte integrante e importante della comunità ecclesiale a cui appartiene.
È utile tenere presente che sempre di più i malati e le persone anziane non autosufficienti abitano le case più che gli ospedali o le strutture di ricovero. Per questo si rende sempre più necessaria una presenza capillare sul territorio di operatori pastorali preparati che, oltre a visitare i malati nei luoghi di cura, frequentino le case di chi in un letto, vive la sua giornata, spesso in solitudine.
Occorre considerare che se la visita del Ministro straordinario della santa Comunione generalmente è rivolta ai soli fedeli cristiani che desiderano l’eucarestia, la visita agli infermi può raggiungere tutti i malati della parrocchia e dei luoghi di cura.
Poiché l’efficacia della relazione pastorale d’aiuto dipende in gran parte dalle qualità umane e spirituali di chi la esercita, può essere utile ricordare alcune attenzioni particolari che l’operatore pastorale che visita gli infermi deve tenere presente, senza la pretesa di voler essere esaustivi sull’argomento.
L’operatore pastorale non porta qualcosa ma testimonia Qualcuno anzitutto attraverso il dono di sé, del suo tempo, del suo cuore ospitale, accogliente della storia del malato nella sua vulnerabile individualità (non ci sono malati ma singole persone malate).
Nella visita all’infermo, l’operatore accoglie i suoi sentimenti di rabbia o di accettazione della situazione, ugualmente nobili. Il protagonista dell’incontro che segna tempi e ritmi del colloquio pastorale è il malato che ha diritto di esprimere quello che ha nel cuore fino anche a gridare, come Cristo in croce “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato” (Mc 15,34).
Per questo all’operatore viene chiesto soprattutto capacità di ascolto della narrazione verbale e non verbale del visitato offrendo all’infermo una comprensione empatica che gli faccia percepire di essere stato accolto e compreso.
Questi atteggiamenti del visitatore possono aiutare il malato a dotare di senso la sua esperienza e assumono valore “sacramentale”; se offerti con gratuità, amore e competenza favoriscono, nel rispetto dei tempi e della sensibilità stessa del malato, l’incontro con Cristo medico nella preghiera, nella Parola di Dio e nei sacramenti.
Non dimentichiamo, inoltre, che laddove non è possibile, per vari motivi, pregare con il malato, è sempre possibile, nel silenzio e in tempi diversi dalla visita, pregare per il malato
(Testo del novembre 2016)
Fonte
Immagine
- Illustrazione di suor Marie-Anastasia Carré (Communauté des Béatitudes)
Dal sito dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI, il commento alla quinta opera di misericordia corporale
(di don Carmine Arice,
direttore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale della Salute 2012 – 2017)
Nel racconto evangelico del giudizio finale (cfr Mt 25,31-46) si legge l’ammonimento di Gesù “Ero malato e mi avete visitato” (Mt 25,36). E’ un ammonimento perché alla sera della nostra vita saremo giudicati sull’amore e non sulle buone intenzioni che avremo avuto. E neppure il nostro atto di fede è sufficiente per essere riconosciuti benedetti dal padre di Gesù Cristo, perché “la fede opera per mezzo della carità” (Gal 5,6), ci ricorda l’apostolo Paolo.
La misericordia “si fa”. Scriveva papa Francesco nella Bolla di indizione dell’anno giubilare: “La misericordia di Dio non è un’idea astratta ma una realtà concreta con cui egli rivela il suo amore come quello di un padre di una madre che si commuovono dal profondo delle viscere per il proprio figlio” (Bolla n. 6). Per questo la chiesa parla di opere di misericordia.
La quinta opera di misericordia corporale è visitare gli infermi. Possiamo pensare che nel verbo “visitare”, vi sia anche il verbo assistere, prendersi cura! La visita agli infermi è un momento privilegiato nel quale la comunità ecclesiale porta la luce e la grazia del signore a coloro che soffrono, riconoscendo con umiltà che il Signore Gesù si è identificato con il malato e non con il visitatore.
Rivestito di “sacramentalità cristica”, il malato chiede al visitatore di condividere una dimensione di spoliazione, di impotenza, di povertà. Egli è espressione della comunità cristiana che desidera incontrarsi con il volto di Cristo sofferente. Riconoscendone la sacramentalità e la sua inalterabile dignità, il visitatore entra nella stanza dell’infermo in punta di piedi e con profondo rispetto.
La sofferenza e la malattia aggrediscono l’uomo come i briganti; nella nota parabola lucana del buon samaritano, hanno aggredito il malcapitato. Con il disagio fisico, il malato sperimenta anche la solitudine che nei casi più gravi può farsi anche disperazione.
Il dolore isola. “Colui che soffre fortemente vede dalla sua condizione, con terribile freddezza, le cose al di fuori: tutte quelle piccole ingannevoli magie in cui di consueto nuotano le cose quando l’occhio sano vi si affisse, sono per lui dileguate; anzi egli si pone dinanzi a se stesso privo di orpelli e di colore”.
Malattia, povertà e sofferenza feriscono la persona, aggravando il disagio fisico con quello morale. La nudità nella quale viene lasciato il malcapitato dalla parabola lucana è icona del pudore violato di ogni malato. In lui sempre albergano, anche se inespressi, la domanda di senso e il peso dei suoi problemi esistenziali.
Visitare il malato significa allora offrire con discrezione, amore e competenza, una vicinanza per attraversare insieme il guado della malattia, sentirsi meno solo e percepire, anche se permanentemente infermo in un letto, di essere parte integrante e importante della comunità ecclesiale a cui appartiene.
È utile tenere presente che sempre di più i malati e le persone anziane non autosufficienti abitano le case più che gli ospedali o le strutture di ricovero. Per questo si rende sempre più necessaria una presenza capillare sul territorio di operatori pastorali preparati che, oltre a visitare i malati nei luoghi di cura, frequentino le case di chi in un letto, vive la sua giornata, spesso in solitudine.
Occorre considerare che se la visita del Ministro straordinario della santa Comunione generalmente è rivolta ai soli fedeli cristiani che desiderano l’eucarestia, la visita agli infermi può raggiungere tutti i malati della parrocchia e dei luoghi di cura.
Poiché l’efficacia della relazione pastorale d’aiuto dipende in gran parte dalle qualità umane e spirituali di chi la esercita, può essere utile ricordare alcune attenzioni particolari che l’operatore pastorale che visita gli infermi deve tenere presente, senza la pretesa di voler essere esaustivi sull’argomento.
L’operatore pastorale non porta qualcosa ma testimonia Qualcuno anzitutto attraverso il dono di sé, del suo tempo, del suo cuore ospitale, accogliente della storia del malato nella sua vulnerabile individualità (non ci sono malati ma singole persone malate).
Nella visita all’infermo, l’operatore accoglie i suoi sentimenti di rabbia o di accettazione della situazione, ugualmente nobili. Il protagonista dell’incontro che segna tempi e ritmi del colloquio pastorale è il malato che ha diritto di esprimere quello che ha nel cuore fino anche a gridare, come Cristo in croce “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato” (Mc 15,34).
Per questo all’operatore viene chiesto soprattutto capacità di ascolto della narrazione verbale e non verbale del visitato offrendo all’infermo una comprensione empatica che gli faccia percepire di essere stato accolto e compreso.
Questi atteggiamenti del visitatore possono aiutare il malato a dotare di senso la sua esperienza e assumono valore “sacramentale”; se offerti con gratuità, amore e competenza favoriscono, nel rispetto dei tempi e della sensibilità stessa del malato, l’incontro con Cristo medico nella preghiera, nella Parola di Dio e nei sacramenti.
Non dimentichiamo, inoltre, che laddove non è possibile, per vari motivi, pregare con il malato, è sempre possibile, nel silenzio e in tempi diversi dalla visita, pregare per il malato
(Testo del novembre 2016)
Fonte
Immagine
- Illustrazione di suor Marie-Anastasia Carré (Communauté des Béatitudes)